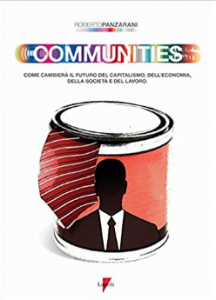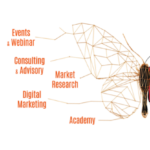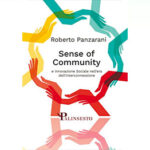Il nuovo capitalismo delle communities
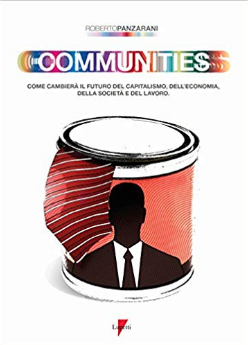 Roberto Panzarani, docente di Innovation Management presso il Crie (Centro de Referência em Inteligência Empresarial Universidade Federal) di Rio de Janeiro, individua nel suo ultimo lavoro: “Costruire Communities. Come cambierà il futuro del capitalismo, dell’economia, della società e del lavoro” (ed. Lupetti) un estremo spazio relazionale del possibile, un ultimo approdo insomma per il modello capitalistico, che in Occidente ha mostrato la corda in questi anni di crisi. “Se il 2008 – spiega l’autore – ha segnato l’inizio della crisi economica e ha mostrato che il neoliberismo è attualmente un modello saturo perché non più in grado di gestire le richieste di un mercato globale sempre più mutevole e incontrollabile e di una classe politica allo sbando, ciò che bisogna fare è cambiare il paradigma, ora e non domani. Le vecchie regole non risultano più valide, questo è il momento in cui dobbiamo inventarne di nuove. L’importante è avere chiara una direzione. E la direzione è quella della rinuncia alla cieca economia del consumo, per giungere a uno scambio sostenibile”.
Roberto Panzarani, docente di Innovation Management presso il Crie (Centro de Referência em Inteligência Empresarial Universidade Federal) di Rio de Janeiro, individua nel suo ultimo lavoro: “Costruire Communities. Come cambierà il futuro del capitalismo, dell’economia, della società e del lavoro” (ed. Lupetti) un estremo spazio relazionale del possibile, un ultimo approdo insomma per il modello capitalistico, che in Occidente ha mostrato la corda in questi anni di crisi. “Se il 2008 – spiega l’autore – ha segnato l’inizio della crisi economica e ha mostrato che il neoliberismo è attualmente un modello saturo perché non più in grado di gestire le richieste di un mercato globale sempre più mutevole e incontrollabile e di una classe politica allo sbando, ciò che bisogna fare è cambiare il paradigma, ora e non domani. Le vecchie regole non risultano più valide, questo è il momento in cui dobbiamo inventarne di nuove. L’importante è avere chiara una direzione. E la direzione è quella della rinuncia alla cieca economia del consumo, per giungere a uno scambio sostenibile”.
Lo studioso segue la scia di grandi pensatori, dal filosofo francese Jaques Attali al Nobel Amartya Sen, che hanno messo al centro del loro impegno la promozione dei valori della responsabilità e dell’etica sociale in economia. In un mondo di disuguali il messaggio che arriva da questo filone di ricerca risulta ancora più importante. Basta fare parlare i numeri. Nel mondo otto uomini, da soli, posseggono 426 miliardi di dollari, la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta, ossia 3,6 miliardi di persone. Ed è dal 2015 che l’1% più ricco dell’umanità possiede più del restante 99%. L’attuale sistema economico favorisce l’accumulo di risorse nelle mani di un’élite super privilegiata ai danni dei più poveri (in maggioranza donne). L’Italia non fa certo eccezione se, stando ai dati del 2016, l’1% più facoltoso della popolazione ha nelle mani il 25% della ricchezza nazionale netta.
Sono alcuni dei dati sulla disuguaglianza contenuti nel rapporto “Un’economia per il 99%” della Ong britannica Oxfam, diffusi alla vigilia del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, nel gennaio del 2017 e richiamati nel saggio di Panzarani. Il trend porta alla facile deduzione che nei prossimi venti anni, cinquecento persone trasmetteranno ai propri eredi 2.100 miliardi di dollari: è una somma superiore al Pil di una grande nazione come l’India, Paese in cui vivono 1,3 miliardi di persone. Vuol dire che i mega Paperoni dei nostri giorni si arricchiscono a un ritmo così spaventosamente veloce che potremmo veder nascere il primo trillionaire (ovvero un individuo con risorse superiori ai mille miliardi di dollari) nei prossimi venticinque anni.
Il grave gap formativo
Di fronte a tutto questo non si può stare a guardare. L’Italia sembra aver curiosamente scelto di “negare” l’innovazione. Un atteggiamento miope che non piace per nulla all’autore. “Se non vogliamo che il nostro destino sia segnato occorre cambiare marcia. Un indice di grave superficialità emerge dagli investimenti nella formazione, che appaiono in netto calo. Dal 2009 al 2015, secondo la ricerca Cranet 2015, le giornate medie dedicate alla formazione erano passate da tre a cinque. Anche i fondi utilizzati avevano subito un incremento rilevante: la percentuale del costo retributivo annuo investito era passato da <=1% nel 59% delle aziende private nel 2009 a oltre l’1% nel 63% delle aziende nel 2015, con un 23% di aziende che dedicava anche più del 3% del costo retributivo annuo agli investimenti in formazione. Ma dopo questa impennata, le imprese hanno scelto di disinvestire, con il risultato che nel 2016 le aziende che si sono servite di formazione sono scese al 20,8%, significa che le persone che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione o aggiornamento professionale sono state 240 mila in meno rispetto al 2015.”
La sharing economy nell’era dell’accesso e della condivisione potrà dare una spinta al sistema, a patto che le organizzazioni aziendali si dimostrino ancora una volta all’altezza. “L’errore più grande – precisa l’autore – sarebbe quello di ‘burocratizzare l’innovazione’. Non è sufficiente progettare un dipartimento ad hoc, uguale a tanti altri settori dell’azienda, perché si deve creare una vera e propria mobilitazione, un coinvolgimento delle persone, che sappia trascinare emotivamente ogni dipendente”.
La sharing economy porta con sé una nuova organizzazione della domanda e dell’offerta, in cui le persone contano finalmente molto di più. Occorre maturare la consapevolezza che in questo nuovo modello economico non varrà più la distinzione tra produttori e consumatori, perchè si va definendo un modello peer in cui soggetti di pari dignità si scambiano beni e servizi sulla base di reciproche promesse, che si tramutano in penalità nel caso in cui non vengano mantenute.
Le communities nel mondo
Il volume si chiude con alcuni esempi di communities nel mondo, dal caso della Nespresso che nel 2003, con la collaborazione di Rainforest Alliance, ha avviato il Programma AAA per una qualità sostenibile del suo caffè, che ha coinvolto i coltivatori della Colombia, all’Arizona, terra in cui è attecchito il sogno ipertecnologico di Bill Gates: Belmont, una smart city sostenibile e digitale che sorgerà vicino Phoenix. Il numero uno di Microsoft ha finanziato con 80 milioni di dollari la realizzazione di questa realtà nel bel mezzo del deserto, per la costruzione di un hub ipertecnologico desinato a rivoluzionare l’idea di città. Altra esperienza interessante ricordata nel libro riguarda la comunità di Arcosanti, fondata nel 1970 dall’architetto Paolo Soleri, ex allievo di Frank Lloyd Wright. Un villaggio che, in tempi non sospetti, ha tentato e tenta ancora di concretizzare l’idea di un ritorno a una vita più sostenibile e collettiva. Ad Arcosanti oggi vivono circa cento persone stabilmente, il sito è frequentato annualmente da almeno 50mila visitatori, fra turisti, studenti e ricercatori. Si tratta di nuove realtà che cominciano a prendere piede. Non sarà facile diffondere questa nuova cultura del business, ci sarà bisogno di rafforzare a tutti i livelli la preparazione manageriale e professionale oltre che di una classe dirigente adeguata, senza di cui sarà praticamente impossibile affrontare con qualche ragionevole chances di successo i profondi cambiamenti che ci aspettano.