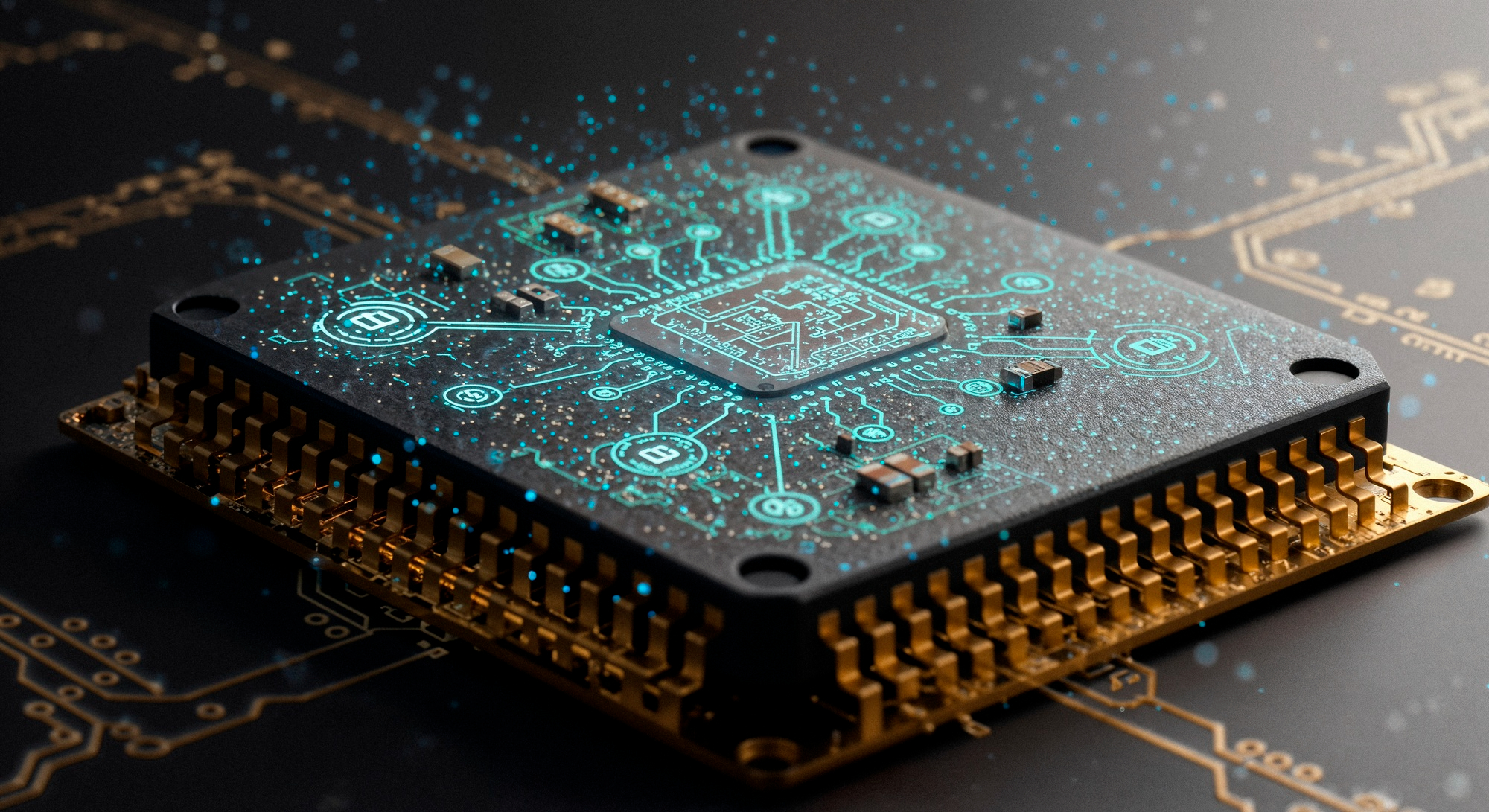Autore: Massimiliano Cannata
“Il rumore delle parole” (ed. Rizzoli) come tutti gli scritti di Vittorino Andreoli è un lavoro impegnativo, che scava nel profondo l’animo umano. L’io narrante si focalizza sull’analisi di quattro termini – chiave: democrazia, assurdità, bellezza, vecchiaia, “una tetrade per me magica” come viene spiegato al lettore nella premessa.
Difficile evitare a tutta prima l’accostamento con il celebre saggio di Michel Foucault: “Le parole e le cose”. Il problema centrale che animava la ricerca del pensatore francese era riconducibile alla rifondazione delle condizioni di verità del discorso scientifico, in un contesto come quello della contemporaneità che aveva scompaginato in maniera definitiva le categorie tradizionali della conoscenza. In questo caso le questioni in ballo sono altre, ma saremmo comunque fuori strada se pensassimo di avere tra le mani un testo di linguistica in senso stretto. Storia, sociologia, politica, antropologia sono molteplici gli ingredienti disseminati nel racconto del protagonista, che parla da una stanza vuota, connesso alla rete. “La virtualità può essere anche un modo per superare la solitudine”. Per chi non ha la fortuna di camminare nel mondo in compagnia, la semplice presenza on line di un interlocutore è comunque una provvidenza da benedire. Questa strana figura di docente potrebbe richiamare il protagonista della novella di Pirandello: “L’eresia catara”. Costretto a fare le sue lezioni senza un vero pubblico, il professore parlava a dei cappotti vuoti, degli allievi nemmeno l’ombra, malgrado questo continuava a parlare spinto dalla necessità di comunicare. Ecco il primo importante elemento di riflessione: la “solitudine virtuale è meglio del vuoto assoluto” può dunque esistere un lato buono della Rete che forse non abbiamo ancora a sufficienza considerato. Se usato con intelligenza Internet può creare comunità, dando effetto concreto a quell’intelligenza collettiva teorizzata da Pierre Levy.
Ma “Il rumore delle parole” è anche, forse più di tutto, un libro sulla vecchiaia di cui non si può e non si deve avere vergogna. “Sono vecchio”, parole del protagonista, un’affermazione inusuale nella sua secchezza. Oggi spesso rimane sottaciuta, ingoiata e inespressa, perché soffocata da un alone di pudore, quasi che questa condizione dell’esistenza debba essere negata e conculcata, travolti come siamo dalla velocità, dall’efficienza ad ogni costo, dalla superficialità. Ci aveva già messo sull’avviso Michel Serres tra gli intellettuali oggi più lucidi e influenti, dando alle stampe un pamphlet dal titolo molto esplicito: “Non è un mondo per vecchi”. Andreoli in maniera implicita ma potente, rincara la dose argomentando con lucidità la ragione per cui sarebbe assurdo negare l’importanza di una stagione dell’esistenza paradigmatica, in quanto specchio fedele di una condizione di fragilità che ci appartiene sempre, fin da quando facciamo il nostro ingresso nel mondo. “La condizione umana si caratterizza per la fragilità, che è data dal bisogno dell’altro, dal desiderio di conoscere, mentre il potere non ha bisogno dell’altro se non per dominarlo. Questo è l’umanesimo della fragilità, che segna e segnerà le nostre vite… Ho, per questo motivo, studiato da sempre con massimo interesse l’uomo rotto, perché in lui ho sempre ritrovato quella grandezza di cui ogni individuo è portatore. Grazie a questa convinzione riesco a guardare avanti con fiducia, definendomi un pessimista attivo”.
L’umanesimo della fragilità, fil rouge del precedente scritto “Homo Stupidus Stupidus”, pubblicato dallo studioso con lo stesso editore, attraversa anche queste pagine. Non c’è da stupirsi: il linguaggio è la “casa dell’essere”, come ci ha insegnato Heidegger, “ci parla”, facendoci ritrovare l’origine, la strada che dalle radici ci ha condotti fin qui, nella ricerca di un’identità e di un posto nel mondo. La “tetrade” alla fine della trattazione rievoca la morte, ma anche l’eternità, scandendo un tempo non solo mentale ma anche cronologico. Lungo il cammino di questa ricerca che non può trovare risposte definitive ci si potrebbe stupire di trovare una parola quale “assurdità” che dovrebbe essere bandita dal corretto ragionamento. Ma è proprio lo “sguardo di lato” che più accende la scintilla del ricercatore e dello studioso: “Misurarsi con la dimensione dell’assurdo – spiega l’autore – significa ritornare a quello che descrive Kierkgaard in “Timore e tremore”. Dio, come è noto, suggerisce ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco. Un controsenso, qualche cosa di inaccettabile per qualsiasi genitore. Abramo riesce comunque a trovare una soluzione, va oltre l’assurdo, segue la regola che ha appreso: sa che Dio c’è, ne ha avuto esperienza. Noi di fronte alle contraddizioni che attanagliano l’uomo contemporaneo a differenza di Abramo non facciamo niente, scappiamo. Il grande conflitto, il dramma è proprio questo: c’è una strada indicata dalla civiltà che ci porta verso l’alto, all’opposto ne esiste un’altra che ci porta verso la regressione. Non dobbiamo mai finire di lottare entrare dentro questa contraddizione per superarla, perché a prevalere sia la tensione verso obiettivi di progresso e di crescita umana e civile, perché di questo, mi creda, abbiamo un bisogno estremo e disperato”.
A conclusione della lettura un monito emerge in maniera netta: nessuno di noi può avere la presunzione di conoscere cosa ci aspetta al di là del mistero, non sappiamo neanche quale sia il confine tra lucidità e follia. Quello che più umilmente possiamo fare è impegnarci a spingere la notte più in là, esercitando la facoltà dell’intelligenza, il valore del rispetto e della tolleranza, cercando di mettere in pratica un metodo di approccio alla realtà fondato sul pensiero critico e sull’ascolto dell’altro. Quell’altro che è “la provocazione che ci chiama all’essere” (per dirla con Alain Badiou), senza di cui noi stessi non avremmo alcuna seria ragione di stare nel mondo